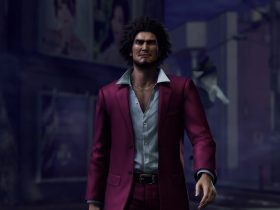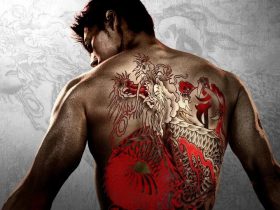Gli occhi di Senua sono gli occhi di una madre disperata, di un’amante abbandonata, di una figlia maltrattata. Gli occhi di Senua sono gli occhi di una donna comune, di quelle alle volte senza nome e senza volto rannicchiate in un angolo buio della mente mentre piangono in silenzio. Nessuno le ascolta, nessuno le sente. È il loro estremo sacrificio. Un anno e più dopo, con l’arrivo sugli scaffali fisici di Hellblade: Senua’s Sacrifice, quegli occhi sono ancora lì. Icona vera di riscatto. Quello ludico, malamente percepito, immaginiamo, da un pubblico non sempre riconoscente verso il genio, il talento. Verso quel coraggio di un team tanto talentuoso quanto incompreso. Quello sociale, solo sfiorato da una critica rimasta divisa dalle qualità di un prodotto atipico, sì, eppure davvero capace di raccontare una storia. Cento, mille, milioni di storie. Di donne e di lotte misteriose, di voci sconnesse e fuori campo, di umani sentimenti e dolorose ferite.
La paura del diverso
La storia di Senua è la storia di una donna. Di un essere umano. Fragile, diverso. Soprattutto, debole. Nonostante quella pesante spada trascinata con forza ed orgoglio, è impossibile pensare a Senua come ad un semplice soldato, come ad un guerriero. Nessuno spoiler. Nessuna rivelazione perché, ci piace crederlo, si tratta di un’avventura da vivere e giocare senza suggerimenti. Piuttosto, è interessante rilevare come i tratti essenziali della protagonista vadano davvero oltre quei paletti canonicamente riconosciuti nel videogioco. Anche e soprattutto quello moderno. Senua non è solo una donna. Senua è una donna vera, un essere umano splendidamente imperfetto chiamato a sconfiggere i demoni creati dalla sua stessa mente. Tragicamente imperfetto, anche. La storia della guerriera utilizza la mitologia nordica come una sorta di pellicola applicata al cervello, tra voci e fantasmi. Nessun dubbio, in sede di catalogazione, su quale sia il genere di appartenenza.
Il dolore del malato
La malattia di Senua è vera, reale, tangibile. Come lo sono le voci che bombardano il suo senno. Come le “matte” visioni che distorcono la realtà, mai così fluida. Hellblade non è stato certamente il primo videogioco a simulare una malattia mentale, tutt’altro. Eppure, è stato probabilmente l’unico ad affrontare il tema del dolore, della morte e della violenza con giuste dosi di sensibilità e, pure, interessanti soluzioni ludiche. Il gameplay del titolo, in ognuna del sue fasi, è strettamente connesso alla malattia. Lo sono, ad esempio, le fasi di esplorazione, dove diventa necessario e, anzi, fondamentale, ascoltare le “voci”, farsi guidare da loro o, al contrario, evitarne l’inganno. Malattia che, nella sua fisicità, ritroviamo nei combattimenti. Ludicamente appagati, tragicamente intensi. Di più: la risoluzione degli enigmi ambientali rappresenta, forse meglio di altri comparti, il doloroso trionfo della follia sulla ragione, con una distorsione del tempo e, soprattutto, dello spazio causata e piegata dalla malattia stessa.
Gli ultimi, i deboli. Senua, magistralmente interpretata da Melina Juergens, è l’incarnazione videoludica di ansia e depressione. Senua, pure, diventa, dopo oltre un anno, il simbolo del riscatto, di quella psicosi che, alle volte, sembra avvolgere un mercato ed un’intera industria sospinta su derive estremamente popolari. Per quella stessa industria, riteniamo, è un bene che esistano giochi come Hellblade. Ed è addirittura fantastico come il titolo, addirittura affossato al debutto dall’insufficienza firmata Edge, arrivi ora sugli scaffali fisici con il favore di una critica internazionale in parte ravveduta e, perché no, gli onori di un pubblico capace, in soli 16 mesi, di elaborare l’opera, di metabolizzarne l’arte. Di sconfiggere i pregiudizi e mettersi alle spalle la malattia. Il sacrificio non è stato vano: Senua ce l’ha fatta. E questo è accaduto davvero.